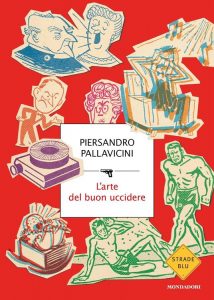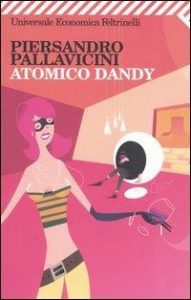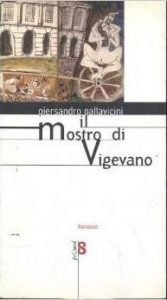“Cinque domande, uno stile” ospita lo scrittore Piersandro Pallavicini. Docente ordinario presso l’università di Pavia, esordisce nel mondo editoriale con “Il mostro di Vigevano” (1999, Pequod Edizioni). Tra gli altri segnaliamo “Atomico Dandy” (2005, Feltrinelli), “Romanzo per signora” (2012, Feltrinelli), “Nel giardino delle scrittrici nude” (2019, Feltrinelli). L’ultimo romanzo è “L’arte del buon uccidere” (2021, Mondadori).
Quando accade, quando un’idea, l’Idea, giunge e prende forma, si rappresenta nel suo immaginario, pronta ad essere modellata per diventare una storia, che sensazione si prova?
Io provo felicità, perché vuol dire che è in arrivo una storia da raccontare, un mondo in cui isolarmi, una tregua dalla realtà. Qualche volta provo anche un senso di liberazione, perché l’Idea si è imposta da sola, è stata la risposta del mio subconscio a un tormento, una difficoltà, o anche una felicità troppo grande, e il senso di liberazione viene dal fatto che so che quando alla fine da quell’idea scriverò una storia, con lo scrivere smorzerò e allontanerò i miei tormenti, le mie ossessioni.
La consapevolezza che la parola appena scritta costituisca la conclusione di un racconto è evidente o necessaria?
È necessaria nel senso che senza quella consapevolezza il racconto, o il romanzo, non finirebbe mai. Scrivere narrativa significa per me creare materiali fluidi, dove l’inizio e la fine non sono ovvii, non sono scientificamente determinabili, allora sulla conclusione occorre decidersi, fare il passo, dire bene così, ora basta. Ed è un processo reversibile: rileggere un file dopo mesi, per esempio, può portarmi a cambiarla, quella parola, a sceglierne un’altra che veniva prima, o a continuare e scrivere ancora e ancora.
C’è stato, nel suo percorso di vita, netto e distinto, un momento di scelta in cui ha affermato a se stesso “devo scrivere?”
Sì, ricordo anche in modo netto quando. Ho iniziato a scrivere tardi, avevo già finito l’università, stavo facendo il dottorato, e ho iniziato a scrivere per una persona. C’erano cose che non ero capace di dirle, cose che le parole di un discorso diretto, esplicito, non sapevano rendere. Scrivere una storia, un racconto, è stato lo strumento con cui quelle cose, quei sentimenti (quei tormenti), ho provato a farli diventare da miei a universali, a dargli un senso e un valore a prescindere dalla loro appartenenza a me, in sostanza a renderli credibili ed evidenti in sé e per sé agli occhi di quella persona. Detto con una formula tanto inflazionata quanto vera: dovevo scrivere per farmi amare.
Lo stile è un passaggio che ciascun autore percorre, può in qualche modo divenire un vincolo?
Lo stile è uno strumento della scatola degli attrezzi di uno scrittore. Rileggevo in questi giorni alcune interviste fatte negli anni 80 a Pier Vittorio Tondelli, che ribadiscono questo concetto che mi trova completamente d’accordo, un concetto che Tondelli aveva espresso anche, mi pare, ne Il mestiere di scrittore (il libro intervista di Fulvio Panzeri e Generoso Picone, uscito per Transeuropa nel 94). Certo, Tondelli è stato un caso estremo soprattutto perché lo stile, nei suoi primi due libri, era mimetico del parlato giovanile, e quando quello scopo (raccontare i ragazzi della sua generazione) è venuto meno, ha anche dovuto giocoforza cambiare attrezzi, cioè stile. Ma credo sia così anche per chi fa salti meno radicali da un libro all’altro: lo stile si adatta alla storia, al contenuto, ai personaggi, alle loro voci, al loro ambiente, ai loro anni. Certo, una tua ‘voce’ inevitabilmente rimane, a forza di scrivere si diventa riconoscibili, certi giri di frasi, certe fluidità, certe scelte lessicali diventano la tua cifra. Ma ecco, non devono diventare un vincolo. Se non racconti sempre la stessa “cosa” (che poi che noia sarebbe), allora scardina, sperimenta, cambia, trova lo stile giusto, la voce più adatta.
In quale misura crede che la letteratura oggi riesca ad incidere nella società e con quale forza lo scrivere costituisca un gesto politico?
Mah, guardi, a questa domanda anche solo due o tre anni fa avrei risposto: zero. Nessuna capacità di incidere, nessun gesto politico. La società se ne fregava di tutto, figurarsi di uno scrittore. Ma adesso no. Adesso c’è una tale richiesta di conformismo benpensante (dal politicamente corretto alla cancel culture, per dire) che scrivere qualcosa che non lo sia è un rischio per l’autore. Ho sempre pensato che si potesse e dovesse scrivere considerando la scrittura un territorio franco in cui poter dire quel che pare all’autore, anche se detestabile, disturbante, contrario alla morale comune. Ecco adesso è sempre più difficile farlo, e chi lo fa, chi pratica l’arte dell’anticonformismo, smuove i sentimenti e le coscienze, instilla dubbi, aizza al ragionamento. L’autore, così, consapevolmente rischia l’ostracismo e, nel farlo, forse meno consapevolmente (chè l’atto creativo non è mica frutto di ragionamento a tavolino), compie un gesto politico