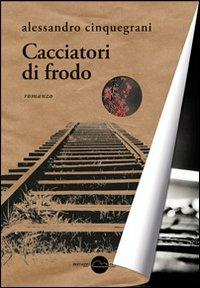“Cinque domande, uno stile” ospita Alessandro Cinquegrani. Saggista, critico letterario e narratore. È docente presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. Autore di numerosi saggi, tra cui “Letteratura e cinema” (2020, Scholé), “L’ innesto. Realtà e finzioni da Matrix a 1Q84” (2015, Mimesis con Valentina Re), “Solitudine di Umberto Saba” (2007, Marsilio), “La partita a scacchi con Dio” (2002, il Poligrafo 2002, Premio Gesualdo Bufalino). Esordisce nella narrativa con “Cacciatori di frodo” (2012, Miraggi, finalista al premio Italo Calvino). Da poco è in libreria l’ultimo romanzo “Pensa il risveglio” (2021, TerraRossa).
Quando accade, quando un’idea, l’Idea, giunge e prende forma, si rappresenta nel suo immaginario, pronta ad essere modellata per diventare una storia, che sensazione si prova?
È sempre molto difficile dire da dove nasca un’idea e come si formi. Per me non nasce mai da un incontro esterno, come può essere la scoperta di una bella storia da mettere su carta. Piuttosto nasce da un’urgenza interiore che si accumula nel tempo e poi prende la forma di una storia con personaggi. Ho sempre l’impressione che scrivere per me sia come lanciare una rete negli abissi della psiche e tirarne fuori pesci, alghe, mostri marini. Sono soprattutto quei mostri che chiedono di essere definiti per poterli esorcizzare. Nel mio primo romanzo, Cacciatori di frodo, hanno preso forma in una donna in sottoveste bianca che si sdraiava su un binario per attendere il treno. Con Pensa il risveglio i mostri sono nati con una frase, “ho sempre sentito il bisogno di scomparire”, che si portava dietro un mondo sommerso, che poi è stato popolato di figure perturbanti, soprattutto Speer e Mengele, ma poi altre figure inventate.
La sensazione che si prova è un coacervo di emozioni complesse. Di solito si cerca di respingere, almeno per me è così, un po’ per l’urgenza della quotidianità che preme continuamente, un po’ perché si sa che aprire le porte a quelle figure sarà faticoso. Se lo faccio è perché mi pare inevitabile e confido che prima o poi porterà sollievo, come in effetti accade.
La consapevolezza che la parola appena scritta costituisca la conclusione di un racconto è evidente o necessaria?
La conclusione di un racconto di solito è l’unica cosa che ho in mente fin dall’inizio, e l’ultima parola di solito è un’apertura, una speranza. Questo funge da faro per scrivere tutto il testo: è come se l’ultima parola fosse la prima, o comunque necessaria per iniziare, anche se comunque scrivo sempre in ordine i capitoli dei romanzi, ma l’ultima sta lì, a ricordarmi che esiste una via d’uscita.
Poi chiaramente la conclusione del racconto non è quasi mai l’ultima parola che si scrive. Ci sono le riscritture che per Pensa il risveglio sono state molte (soprattutto di alcune parti) e invece per Cacciatori di frodo non ci sono state.
C’è stato, nel suo percorso di vita, netto e distinto, un momento di scelta in cui ha affermato a se stesso “devo scrivere?”
A conti fatti credo siano state molte di più le volte nelle quali mi sono detto “non devo scrivere”: la mia è stata un’ostinata colluttazione con una necessità dalla quale sono uscito sconfitto. Bisognerebbe evitare di scrivere per tanti motivi: perché si scrive e pubblica troppo (Non incoraggiate il romanzo era un bel titolo di Berardinelli), perché si alimentano illusioni, perché per chi come me fa il critico si entra in conflitto con se stessi ecc. Ma, come dico, nel tempo, prima o poi, ho sempre ceduto. Da ragazzo con la poesia – avevo pubblicato un libretto intitolato Nel mio corpo materia o nell’altro – poi con la prosa.
Il mio primo tentativo di romanzo – che lesse solo qualche amico – risale a quando avevo poco più di vent’anni, ma la cosa interessante e quasi stupefacente per me, è che era strutturato esattamente come Pensa il risveglio. Ovviamente non ne aveva la complessità, e era fondato su una storia giovanilistica e un amore adolescenziale, però la struttura di base, la prospettiva di tutta la prima parte e poi il cosiddetto risveglio, era già lì.
Poi, come per tutti, ci sono i momenti di svolta – veri o presunti – in cui si comincia a credere che forse bisogna aprire le porte alla scrittura. Uno di questi fu quando uno dei correlatori della mia tesi di laurea – un professore ordinario che stimavo (e stimo) molto e che guardavo con un certo timore reverenziale – mi convocò nel suo studio, nel quale entrai tremando, e la prima cosa che mi disse è: “lei ha una prosa da scrittore!”. Poi però continuai a dedicarmi alla critica, finché dopo aver vissuto alcuni anni a Venezia, tornai a vivere nella mia città natale, Treviso, con la quale ho sempre avuto un pessimo rapporto: nacque così, quasi per una necessità di liberazione, il mio primo romanzo, Cacciatori di frodo. Poi venne il Premio Calvino e iniziò la storia con la narrativa. Ma ci ho messo dieci anni per tornare a pubblicare, tanto è servito per perdere la ultima colluttazione con la narrativa e abdicare una volta di più al mio proposito di scomparire.
Lo stile è un passaggio che ciascun autore percorre, può in qualche modo divenire un vincolo?
Sì. Ho sempre pensato che in Italia lo stile sia sopravvalutato, come fosse in qualche modo separato dall’intreccio e avesse una vita autonoma al di là di ciò che si racconta. Io non credo sia così. Nessuna storia può esistere senza il suo stile, almeno se si intendono le storie come dicevo prima, cioè come esperienze e non come narrazioni affabulatorie. Quindi ogni storia pretende uno stile, e ogni narratore una voce. Però anche un autore ha una voce sua, una sua cifra, che anche se fosse il più grande trasformista non riuscirà mai a dissimulare – e del resto probabilmente non sarebbe un bene se ci riuscisse totalmente. Quindi anche lo stile vive un conflitto, nasce dalla convergenza tra ciò che la storia pretende e ciò che un autore può avere nella penna.
Io ho vissuto questo conflitto in modo abbastanza drammatico (uso questo termine enfaticamente, ovviamente parliamo di questioni marginali rispetto a molte altre). Il mio primo romanzo Cacciatori di frodo aveva uno stile molto particolare, ossessivo, ripetitivo, circolare: nell’economia di quel libro ha un ruolo molto ingombrante. Ed era il solo romanzo che avessi pubblicato. Io come autore ero quel libro. Per molto tempo avevo la percezione che quello stile non potesse essere riproposto perché troppo legato a quella storia, ma pensavo anche che io come autore ero quello. Più che un vincolo era diventato una condanna.
A volte mentre scrivevo la prima stesura di Pensa il risveglio quello stile si riaffacciava e io lo respingevo, perché la mia voce in realtà era un’altra, che mi piace di più, che trovo più matura. Ho lavorato su questo nuovo stile in alcuni racconti che ho scritto per raccolte alle quali mi hanno chiesto di partecipare, in particolare nel racconto La vocazione di San Matteo e poi I fratelli Vendramin usciti in raccolte curate da Cristiano Dorigo e Elisabetta Tiveron. Le sollecitazioni di queste persone, e poi quelle di Gianluigi Bodi per altri racconti, mi sono state utilissime per trovare una voce mia e partire da qui per confrontarmi con altre storie.
In quale misura crede che la letteratura oggi riesca ad incidere nella società e con quale forza lo scrivere costituisca un gesto politico?
Recentemente mi è capitato di conversare con Carla Benedetti, Antonio Moresco e Tiziano Scarpa sul libro La letteratura ci salverà dall’estinzione. Ovviamente si parla di qualcosa di molto più importante che incidere nella società. Una dottoranda della nostra università mi diceva che l’ipotesi è molto suggestiva ma in fondo è falsa: la letteratura ha perso tutto il suo ruolo sociale. Non so da che parte stia la verità, probabilmente nel mezzo.
Qualche tempo fa un’amica che lavora in ambito farmaceutico mi diceva, senza troppi peli sulla lingua, che la sua ricerca salva le vite umane e la mia è totalmente inutile. Risposi che se non ci fosse stato un movimento culturale come quello dell’illuminismo, probabilmente i suoi farmaci sarebbe arrivati a un’esigua minoranza di persone, quindi, delle vite umane che i suoi farmaci salvano, almeno il 90% è ascrivibile a un cambio di paradigma culturale.
Tutti noi lettori più che occasionali ricordiamo un libro che ci ha cambiato il modo di essere e di pensare o ha modificato la nostra visione del mondo. In fondo è questo quello che chiediamo a un libro, non certo di farci passare qualche ora della nostra minuscola vita che avremmo potuto dedicare a giocare coi nostri figli o a fare una passeggiata salutare. In questo senso ogni libro in grado di modificare la nostra visione del mondo è un libro politico. Ma io penso che questo debba avvenire senza proclami o manifesti, senza messaggi di natura politica o sociale (come temo vada di moda recentemente). La politica può entrare in una narrazione attraverso i gesti, i rapporti, le aspirazioni dei personaggi. Kafka è politico, ma quando parla di politica nei suoi romanzi?
[the_ad_placement id=”spot”]