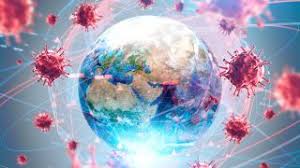Siamo fatti di parole e nelle parole segniamo la differenza. Dire in un contesto del genere di essere in guerra è abusare delle parole, e in questo caso della parola.
Guerra è altro. La guerra è qualcosa che ti entra dentro, fino a casa a strappartela di netto quella casa a tranciare d’impatto le vite d’ognuno senza che spesso se ne abbia consapevolezza.
La guerra è privazione e abbattimento delle libertà in uno stato pressoché definitivo.
La pandemia che viviamo è ben altro, difficile da affrontare senza dubbio, ma fortunatamente distante dallo stato di guerra.
E quest’insistere sulla terminologia guerresca tende come sempre ad unire contro il nemico. Perché per natura l’uomo si compatta se vede un nemico all’orizzonte.
Ma un nemico non c’è. Una malattia o qualcosa che una malattia può generare non è un nemico, è semplicemente un evento – doloroso, di certo – da affrontare, non combattere.
Non si combatte una malattia, la si affronta, la si contrasta – nelle accezioni mediche e farmacologiche – o vi si convive alla fine, quando ogni possibilità di guarire è preclusa.
In questo caso dobbiamo imparare a convivere, adottando le precauzioni del caso, rimodulando gli stili di vita. La resistenza che si invoca non è di carattere personale o sanitario, sia ben chiaro, ma semplicemente economico. Dobbiamo in qualche modo resistere affinché quel castello di consumi che abbiamo concorso a costruire resista a quest’immane botta subita.
Resista affinché non ci siano rovine da rimettere in piedi ma pareti crepate da ristrutturare.
Altra questione la prigionia. Cos’è essere prigionieri? Restarsene a casa forse? Non direi. Non potersi scolare qualche birra al bar? Non direi. Non potersi fregiare dell’ultima suppellettile prodotta? Non credo.
Al netto dei nervi scoperti viene fuori il tendine più abusato e sfilacciato. L’incapacità di vivere la comunità per quello che è. Qualcosa di comune, in cui in maniera solidale ci si dà tutti una mano, per quanto singolarmente possibile. Comunità è armonia di suoni diversi in cui ciascuno concorre a disegnarne la figura.
Fortunatamente non sarà una questione definitiva, ma transitoria. Il rifugio delle nostre case – per chi ne ha possibilità – è momentaneo. La compressione cui tutti siamo direttamente o in via indiretta costretti si riduce a qualche settimana. Non c’è una compressione definitiva, così come accade per chi è e resta prigioniero del proprio corpo, incapace di effettuare i benché minimi movimenti.
Siamo adesso tutti diversamente abili, di abilità differenti rispetto al solito modo di vivere. E non è una questione di riscoperta di valori differenti, perché se così la si pensa, allora si dovrebbe riconsiderare tutto il vissuto precedente per il quale non si è avuta la capacità di riflettere sulle questioni importanti che riguardano la vita e il mondo.
Non ne usciremo migliori, ne usciremo in qualche modo per ciò che siamo capaci di fare o non fare, essere o non essere.
E non è un bel dilemma da teatro è una questione epocale che ci trova piccoli, fragili e impreparati.
[the_ad_placement id=”spot”]