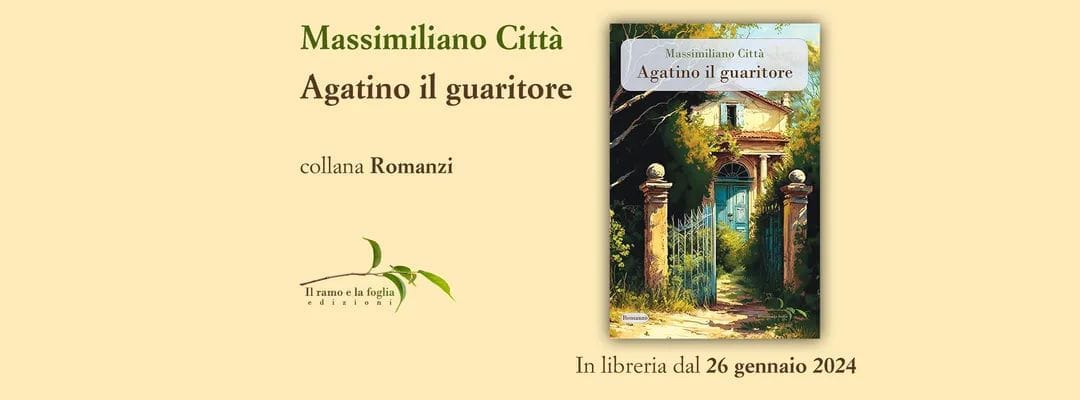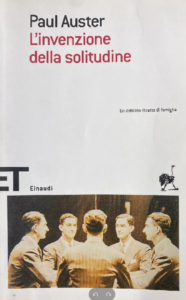L’invenzione della solitudine – Paul Auster (Einaudi, 1997 – pp 179)
“Ciascun libro è un’immagine di solitudine, un oggetto concreto che si può prendere, riporre, aprire e chiudere, e le sue parole rappresentano molti mesi, se non anni, della solitudine di un individuo, sicché a ogni parola che leggiamo in un libro potremmo dire che siamo di fronte a una particella di quella solitudine. Un uomo solo è seduto in una stanza e scrive…”
L’invenzione della solitudine cammina sospeso sul filo tra il memoir e la meditazione filosofica. Racconto d’indagine interiore e, per certi versi, saggio sulla memoria, fu pubblicato nel 1982, segnando l’esordio dello scrittore americano nel genere di prosa autobiografica.
Riportando le considerazioni delle pagine finali “Tutto questo avvenne domani. Tutto questo fu tra cento anni.” il libro appare come l’incipit e al tempo stesso la summa della sua futura produzione.
“Possiamo evitare confronti spiacevoli, sia con noi stessi sia con gli altri, soltanto allontanandoci.”
Il testo si suddivide in due parti distinte, ma intimamente connesse.
Nella prima, Ritratto di un uomo invisibile, Auster esplora la figura paterna, tentando di ricomporne la memoria attraverso un’indagine frammentaria sui segreti e sulle omissioni che ne hanno segnato l’esistenza.
“C’è stata una ferita, e scopro adesso quanto fosse profonda. Invece di guarirmi come pensavo, l’atto di scrivere l’ha tenuta aperta.”
La scrittura è precisa, senza ridondanze, essenziale, quasi fredda, come se il tentativo di avvicinarsi alla vita del padre venga ostacolato da un velo di ineluttabile distanza. Il ritratto che ne viene fuori è quello di un uomo enigmatico, sfuggente, la cui assenza emotiva grava sulla coscienza del narratore come un inganno.
Il titolo stesso del capitolo suggerisce la percezione di un’ombra, di una presenza che si manifesta per sottrazione.
“Disgiunto da tutto ciò che gli era familiare, incapace di distinguere anche un solo punto di riferimento, vedeva che i suoi passi, non portandolo in alcun luogo, non lo portavano altrove che dentro se stesso. Stava errando all’interno di se stesso e si era smarrito. Invece di turbarlo, quello stato si rivelò una fonte di felicità e di gioia. Si sforzò di insufflarlo fin nel profondo delle sue ossa: come sull’orlo di una conoscenza fino allora nascosta, lo insufflò nelle ossa e proclamò a se stesso, quasi trionfante: io sono perduto.”
La seconda parte, Il libro della memoria, si apre invece a una riflessione più ampia sulla solitudine e sul ruolo del caso nelle vicende umane.
Qui la narrazione si fa più frammentaria, quasi aforistica. Riportando passi di altri autori, Auster si avvicina al saggio, in uno stile sperimentale e concettuale tipico della sua produzione matura. L’autore esplora il rapporto tra memoria e identità, tra scrittura e sopravvivenza, interrogandosi sul modo in cui il passato si sedimenta nella coscienza e nella lingua. Il tema del caso, fondamentale nella poetica austeriana, emerge con prepotenza, delineando un universo in cui gli eventi sembrano seguire una logica misteriosa, imperscrutabile.
“Se un uomo vuole essere davvero presente fra le cose che lo circondano, non deve pensare a se stesso, ma a quello che vede. Deve dimenticare se stesso per essere lì […] Perché la storia della memoria è una storia di sguardo; e rimane una storia di sguardo anche se le cose che si devono vedere non ci sono più.´[…] se è vero che il mondo si imprime nella nostra mente, è anche vero che le nostre esperienze si imprimono nel mondo.”