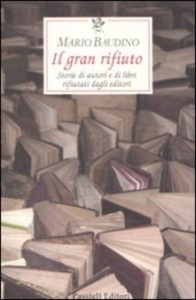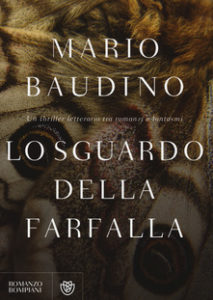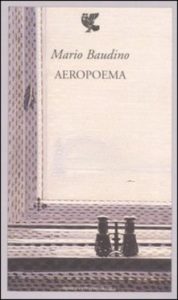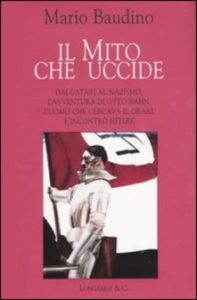Mario Baudino è un piemontese che nelle parole vive. Da sempre. Ha iniziato ad inseguirle per farne articoli di cronaca (da anni è giornalista per la Stampa), le ha messe insieme quelle parole, talvolta scremandone la natura fino a ridurle alla loro essenza poetica – Aeropoema (2006, Guanda) è un esempio tra i molti – altre volte le ha composte per raccontare il mondo e la sua storia – “Voci di guerra. 1940-1945. Sette storie d’amore e di coraggio” (2001, Ponte alle Grazie), “Il mito che uccide” (2004, Longanesi) – altre, invece, le ha usate per costruire realtà d’altrove come nei romanzi “In volo per affari” (1994, Rizzoli), “Il sorriso del druida” (1998, Sperling & Kupfer – vincitore del Premio Scalea), “Per amore o per ridere” (2008, Guanda), “Lo sguardo della farfalla” (2016, Bompiani vincitore del Premio Cesare Pavese).
In occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo, “Il violino di Mussolini” (2019, Bompiani), risponde alle cinque domande.
Quando accade, quando un’idea, l’Idea, giunge e prende forma, si rappresenta nel suo immaginario, pronta ad essere modellata per diventare una storia, che sensazione si prova?
Somerset Maugham spiega in uno dei suoi intelligentissimi saggi letterari – intelligentissimi e piuttosto svagati – che una storia, un romanzo o un racconto nascono così (cito a memoria): ti accorgi che ti è venuta un’idea, cominci a pensarci, torna sempre più spesso, diviene un’ossessione: “e allora con grande fatica scrivi per potertene liberare.”. Mi pare una descrizione piuttosto esatta. Nel mio caso mi accorgo solo dopo un po’ che è arrivata un’idea, diciamo quando sta già diventando una (piccola) ossessione. La sensazione è di stupore prima, di preoccupazione poi, e infine non c’è più sensazione alcuna. Si comincia a lavorare.
La consapevolezza che la parola appena scritta costituisca la conclusione di un racconto è evidente o necessaria?
È necessaria, ma non sufficiente. Almeno nel mio caso. I miei scritti i prosa, non solo quelli narrativi, sembrano non finire mai. Alla fine è necessario una sorta di duello per mettere un punto fermo. In altri termini, per metterli a tacere.
C’è stato, nel suo percorso di vita, netto e distinto, un momento di scelta in cui ha affermato a se stesso “devo scrivere?”
Sì, intorno agli anni dell’Università. Mi sono accorto che era la sola cosa in grado di darmi quell’eccitazione e quell’intensità che taluni chiamano gioia. Decisi che avrei scritto, anche se non sapevo che cosa. Infatti per molti anni finii per dedicarmi al giornalismo e un po’ alla critica letteraria.
Lo stile è un passaggio che ciascun autore percorre, può in qualche modo divenire un vincolo?
Lo stile, per me, è tutto. Finché non so “come” scriverla, una storia rimane al livello di ossessione. Devo trovare lo stile che mi sta oscuramente chiedendo. E’ anche un vincolo, ma necessario. A un certo punto ti accorgi che è quello e non altro, almeno per quanto riguarda il libro o il racconto o il saggio che stai scrivendo. Non credo agli autori che hanno lo stesso stile per tutto l’arco della loro attività: persino Gadda, che pure è così riconoscibile e inimitabile, cambia in ogni libro.
In quale misura crede che la letteratura oggi riesca ad incidere nella società e con quale forza lo scrivere costituisca un gesto politico?
Scrivere è sempre un gesto politico, a mio avviso, perché interviene sul linguaggio, che è sociale e politico direi senza rimedio, quasi una condanna. Vale per la letteratura, ma anche per gli scribacchini, diciamo coloro che puntano consciamente o inconsciamente al puro intrattenimento, al luogo comune, alla immediata biunivocità con i lettori – e per lo più fanno danni, sociali e culturali. Detto questo, la società ci può ignorare (accade alla gran parte degli scrittori) ma intanto qualcosa è accaduto. Sono state poste domande. Come dice Javier Cercas, il lettore (eventuale) è stato ricondotto al “punto cieco”, dove avviene il passaggio di testimone. Ora tocca a lui.
[the_ad id=’4306′]